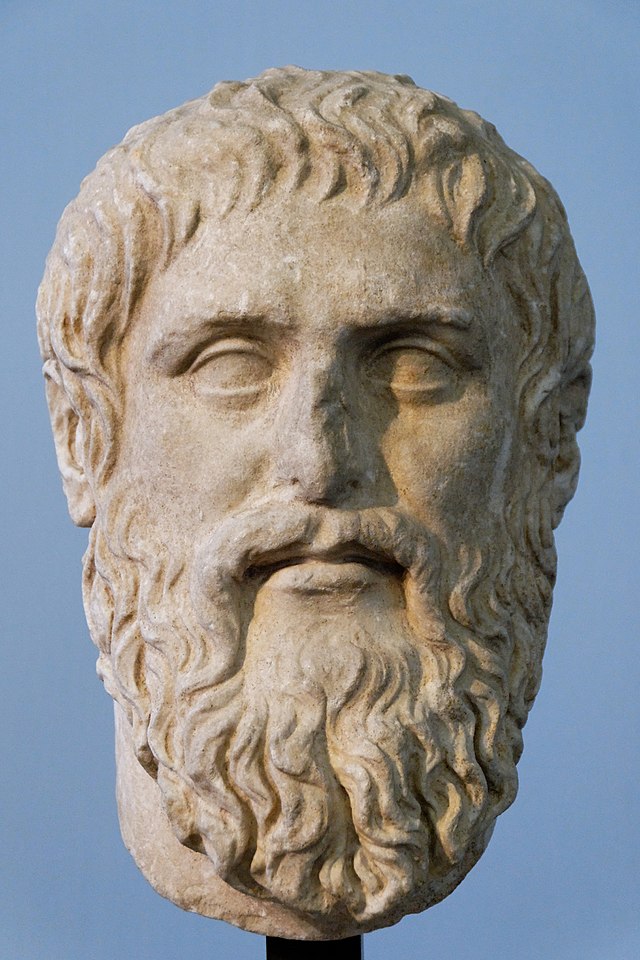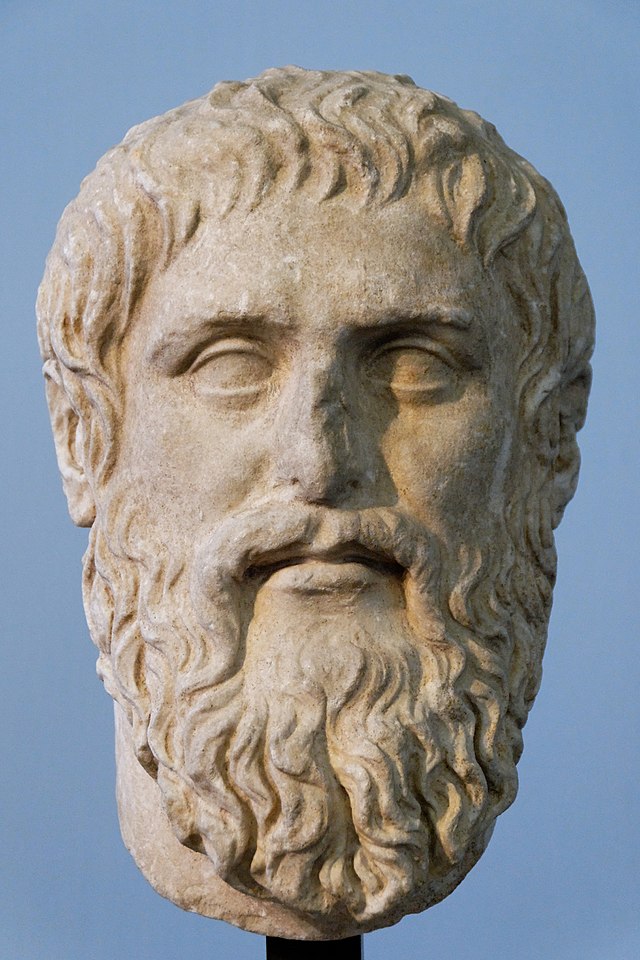
Il relativismo è senza
dubbio una delle filosofie oggi più di moda, soprattutto, ma non
solo, nella forma di relativismo culturale. Cosa sia il relativismo
culturale è presto detto. Secondo questa concezione non esistono
norme razionali né valori morali validi per tutti gli esseri umani.
Al contrario morale e razionalità valgono solo all’interno di
determinati contesti culturali. Pretendere ad esempio che la
razionalità scientifica così come è nata e si è sviluppata in
occidente possa valere anche in contesti culturali non occidentali è
una pericolosa forma di imperialismo. Ancora di più lo è la
“pretesa” che concetti come libertà individuale, democrazia,
diritti umani possano valere in tutte le culture. Dal fatto che
razionalità e valori sono interni ai contesti culturali e validi
solo in questi discende che ogni confronto fra culture è
impossibile e a maggior ragione lo è stabilire qualsiasi tipo di
gerarchia fra culture. Affermare che la tal cultura è, sotto certi
aspetti, superiore alla tal altra è, di nuovo, una pericolosissima
forma di imperialismo: le culture sono “diverse” fra loro ma
nessuna cultura può essere considerata “superiore” a un’altra.
Le conseguenze
pratiche di queste concezioni sono sotto gli occhi di tutti. Se un
marito milanese picchia la moglie di Lodi tutti insorgono di fronte a
tanta brutalità. Le femministe saranno naturalmente in prima linea
nel reclamare la severa punizione del bruto. Ma se a picchiare la
moglie è un marito islamico, se oltre a picchiarla questi le
impedisce di uscire, di mostrare il volto, se la costringe a vivere
con le altre tre o quattro mogli che compongono il suo harem allora
si assiste al più imbarazzato dei silenzi, l’ardore delle
femministe si dissolve, se qualcuno osa bollare come “barbarico”
un tale comportamento è additato al pubblico disprezzo come
“razzista”; può succedere, come è accaduto alla compianta
Oriana Fallaci, di vedersi incriminare per “oltraggio alla
religione islamica”.
Il linguaggio segue
una simile sorte. Occhiuti censori vigilano per espurgare dal
vocabolario tutti i termini che contrastino in qualche modo la
dittatura culturale del “politicamente corretto”. Parole come
“Superiore” o “inferiore” sono praticamente vietate, se
riferite alle società umane. Non si può mai parlare di “usanze
barbare” se ci riferisce a civiltà non occidentali, chi
assimilasse alla “superstizione” le medicine primitive sarebbe
bollato di “imperialismo culturale”, lo stesso uso del termine
“primitivo” è alquanto sospetto. Naturalmente se ci si riferisce
invece alla civiltà ed alla cultura occidentali le cose cambiano. Il
massacro degli indiani d’America può tranquillamente esser
definito come tale (magari aumentando il numero dei massacrati che
secondo alcuni giornalisti televisivi ammonterebbero a milioni, cifra
irrealistica se si tiene conto che il nord America agli inizi della
colonizzazione era abitato da non più di 4/500.000 nativi…), i
crociati erano “crudeli conquistatori” (e gli islamici che misero
a ferro e fuoco mezza Europa?) e così via. Già nell’uso che ne
fanno i suoi sostenitori il relativismo inizia a mostrare le sue
aporie: vorrebbe che tutte le culture fossero “uguali” ma si vede
subito che alcune sono “meno uguali” di altre. Pretende di essere
una concezione anti-autoritaria ma stabilisce regole e divieti; i
relativisti strillano contro “l’imperialismo culturale” ma
fanno della loro dottrina una nuova forma di imperialismo culturale,
proprio mentre chiedono tolleranza i relativisti si dimostrano
arroganti ed intolleranti.
Naturalmente il
relativismo culturale contiene alcuni importanti elementi di verità.
E’ innegabile che le concezioni morali varino da cultura a cultura
e da una epoca storica all’altra. Le stesse norme razionali non
sono esattamente le stesse in civiltà diverse così come in
differenti civiltà ed epoche storiche cambia la concezione stessa di
ciò che è la razionalità. Se il relativismo si limitasse ad
evidenziare e valorizzare questi innegabili fattori di diversità
sarebbe una dottrina del tutto accettabile. Ma così non è. Il
relativismo non si limita a sottolineare il carattere culturalmente
condizionato di norme e valori, nega che esistano valori e norme
universali, validi, almeno potenzialmente, per tutti gli esseri umani in quanto esseri
umani. Per un relativista ad esempio la libertà non è un valore
universalmente valido che alcune civiltà possono tutelare, altre
interpretare secondo propri parametri, altre ancora rifiutare. No,
per il relativista il fatto che alcune civiltà rigettino il concetto
stesso di libertà dimostra che tale concetto è del tutto privo di
interesse per gli esseri umani che fanno parte di quelle civiltà. Se
un occidentale deve subire un arresto arbitrario è legittimo
protestare, se lo subisce un iraniano la protesta è priva di senso
perché nella civiltà islamica la libertà individuale non avrebbe
valore. E se gli esseri umani cge vivono in quella civiltà
protestano per gli arresti arbitrari? Se si dichiarano
innocenti e chiedono che la loro colpevolezza venga dimostrata in un
pubblico processo? Se reclamano garanzie giuridiche? Se, insomma,
chiedono a gran voce cose che sono nate in occidente, ma non solo, e fanno parte a
pieno titolo della civiltà occidentale? Che dire delle loro
proteste? Esse sono legittime o dimostrano solo che questi esseri
umani si sono fatti fuorviare dall’imperialismo culturale
dell’occidente? Ma, se norme e valori valgono solo all’interno di
una certa cultura come può una norma che è parte di questa cultura
“fuorviare” un essere umano nato e vissuto in un contesto
culturale del tutto diverso? Non sarà che il fatto di essere un
uomo, genericamente un uomo, è più importante del fatto di essere
“occidentale” o “mussulmano” ?
Questo in effetti è
il punto centrale. Per i relativisti culturali la cultura (o la
civiltà) vengono prima degli esseri umani, non esistono individui,
persone, esistono membri di determinate civiltà. Un islamico è
islamico ben prima di essere uomo. Costoro sono pronti ad indignarsi
per le violazioni della libertà... se si tratta della libertà delle
culture. Il filosofo Massimo Fini lo ha detto con
molta chiarezza. Allontanare dal potere lo sceicco Omar in Afganistan
ed indire in quel paese libere elezioni è stato un atto oppressivo e
imperialista nei confronti della cultura islamica. Omar rappresenta
la tradizione, la cultura dell’Afganistan, le libere elezioni non
sono altro che una imposizione al popolo afgano di usi e costumi
occidentali. Per Fini è del tutto ininfluente stabilire se gli
afgani siano o non siano stati lieti di partecipare alle elezioni.
Per lui non esistono gli afgani o gli iracheni, esistono le
“culture”, le “civiltà” considerate alla stregua di super-
persone metafisiche che vengono prima, molto prima, degli esseri
umani in carne ed ossa. Per Fini non sono gli uomini a fare le
civiltà e le culture, sono queste a fare quelli e a farli
integralmente. L’uomo cessa di essere condizionato dall’ambiente
culturale in cui vive per risolversi integralmente in esso.
Naturalmente, poiché
culture e civiltà non esistono come super-persone
metafisiche il compito di dar voce a queste entità misteriose spetta
a certi super-individui. Lo sceicco Omar “rappresenta” la cultura
Afgana, allo stesso modo in cui Hitler “rappresentava” la nazione
tedesca o Stalin il “proletariato mondiale”. Che il signor Alì,
afgano, o il signor Strauss, tedesco, o il signor Rossi, operaio
metalmeccanico, non si riconoscano in Omar, Hitler o Stalin è del
tutto privo di importanza per filosofi “a la” Fini. La negazione
del valore degli individui va di pari passo con la attribuzione di un
super valore ai super-individui.
Il relativismo culturale
è del tutto legittimo se inteso nel senso “debole” di
condizionamento che le culture esercitano sulla vita ed il pensiero
degli esseri umani. Inteso in senso “forte” come riduzione
dell’uomo al contesto socio-culturale il relativismo è invece
palesemente assurdo e auto-contraddittorio.
Accettiamo per un
attimo l’ipotesi che la razionalità sia un fatto culturale che
vale solo in un certo contesto. Non esistono norme razionali valide
universalmente, esistono norme che valgono per la cultura
occidentale, altre per quella “islamica” e così via. Se questo
fosse vero avrebbe senso parlare di “altre culture”? No,
ovviamente. Il significato stesso del termine “altra” e del
termine “cultura” sarebbe interno ad
una certa cultura e solo all'interno di questa avrebbe senso parlare di culture "altre". Mai nessun discorso sull'altro potrebbe rimandarci
qualcosa di realmente esterno al contesto in cui si svolge il
discorso. Per i relativisti non esiste nulla di esterno al contesto
ma proprio questo distrugge radicalmente ogni riferimento a contesti
diversi. Io posso dire che la civiltà A è diversa dalla civiltà B
solo se dispongo di norme razionali universali che mi permettano di
esaminare le caratteristiche di A e B, confrontarle, giudicarle
diverse. Se queste norme valgono solo in A o in B ogni dichiarazione
di diversità fra B ed A è illusoria.
L’impossibilità di
uscire dal contesto è un leit-motif dei relativisti ma proprio
questo rende del tutto privo di senso un altro dei punti forti del
loro discorso: il richiamo costante al valore dell’”altro”. Ben
lungi dal valorizzare “l’altro” il relativismo lo distrugge,
ben lungi dall’agevolare il dialogo fra culture il relativismo
riduce le varie culture a monadi incomunicabili. Se questo non appare
è solo perché il relativismo non è coerente con le sue premesse.
Accade ai relativisti ciò che accade ai critici del principio di non
contraddizione. Chi critica tale principio lo usa mentre lo critica,
allo stesso modo i relativisti usano norme razionali universali per
poter parlare della riduzione di tutta la razionalità ai diversi
contesti culturali.
Il relativismo culturale
non è ovviamente la sola forma di relativismo. I relativismi sono
potenzialmente infiniti. A cosa un certo valore, una certa norma ecc.
devono essere relativi? Al contesto culturale, o alla civiltà cui gli individui appartengono dicono alcuni, ma
perché proprio a quelli? Se il relativismo vale quando si esaminano e si confrontano diverse civiltà o diversi contesti culturali, perché non dovrebbe valere quando ad essere esamiati e confrontati sono sono usi e costumi, idee e valori interni ad una certa civiltà, o ad un certo contesto culturale? Esiste un relativismo linguistico, per cui
tutto vale solo all’interno di un certo linguaggio. Non esiste una
realtà empirica cui il linguaggio si riferisce, la realtà è
interna al linguaggio, alle sue norme semantiche e sintattiche (ma un
linguaggio non è esso stesso una realtà empirica? E non si
riferisce a tale realtà la frase “tutto è interno al
linguaggio”?). Per Nietzsche “non esistono fatti ma solo
interpretazioni” (ma questo è un fatto o una interpretazione?). Le
femministe hanno contestato i valori umani per sostituirli con valori
“maschili” o “femminili”, i marxisti sono invece teorici del relativismo socio economico. Parlano di morale
“borghese” o “proletaria”, a suo tempo qualcuno di loro parlò anche
di “scienza proletaria”, “arte proletaria” da contrapporre
alle decadenti scienza ed arte “borghesi” e così via... l’elenco
può allungarsi all’infinito. Il più serio di tutti resta il
vecchio Protagora secondo cui “l’uomo è la misura di tutte le
cose”. In effetti perché ciò a cui una norma o un valore vanno
relativizzati deve essere una misteriosa entità metafisica, la
civiltà, la donna, il proletariato? Se A è relativo a qualcosa
nessun “qualcosa” è più reale, concreto dell’uomo, ma non
l’uomo astratto, metafisico, no, l’uomo concreto, quel certo
uomo: Mario, Luigi, Giacomo. Per Mario lo zucchero è dolce, ma a
Luigi, che è malato, esso appare amaro. Giacomo ride di una barzelletta, ma Paolo, che ha un diverso senso dell'humor, resta del tutto
indifferente ad essa. Non la “civiltà”, il “linguaggio”, il
“proletariato” ma il singolo essere umano è ciò a cui tutto è
relativo. La distruzione dell’universalismo è così finalmente
completa, la conoscenza non esiste, tutto è frammentato fra tanti
singoli privi di ogni contatto fra loro.
Protagora è molto più
serio dei suoi emuli successivi e Platone lo prende in effetti molto
sul serio. Nel “Teeteto” Il Socrate platonico immagina di
chiedere al relativista Protagora cosa ne pensa di ciò che affermano
numerosissime persone secondo cui la verità esiste. Costoro hanno
torto o ragione? Se Protagora afferma che hanno ragione contraddice
ovviamente la sua dottrina, se dice che hanno torto riconosce che
esiste un criterio intersoggettivo di verità che permette di
distinguere il torto dalla ragione e la sua dottrina viene così
egualmente contraddetta. Se tutto è relativo è relativo
anche il relativismo: la conclusione platonica vale contro
Protagora come contro tutte le successive forme di relativismo. Chi
sostiene la “verità” del relativismo si contraddice da solo,
oggi come 2500 anni fa.
Naturalmente un
relativista non si lascerà impressionare da questi ragionamenti. Per
lui si tratta solo di “dogmatismo”. L’argomentazione platonica
vale per il Socrate platonico, non per il relativista Protagora. Per
il Socrate platonico la dimostrazione razionale della fallacia del relativismo è
valida, per Protagora no... tutto qui. Il relativista può usare la
ragione, quando gli aggrada ma può smettere di usarla quando gli
aggrada non usarla, esattamente come il critico del principio di non
contraddizione si arroga il diritto di usare tale principio quando il
suo uso gli fa comodo. Come l’irrazionalista il relativista ha
sempre ragione, gli basta dire: ”per me è così”. Una dottrina
che dice di basarsi sulla tolleranza, sul “rispetto dell’altro”
dimostra ancora una volta di avere nella forza il suo unico
fondamento.
Il relativista non nega
valore universale solo alle norme razionali. Oggetto del suo
nichilismo sono anche, e soprattutto, i valori morali.
Ogni cultura ha i
suoi criteri per valutare di ciò che è bene o male afferma il
relativista e fin qui può vantare alcune solide ragioni. Partito da
questa premessa in parte condivisibile il relativista salta a
conclusioni inaccettabili. Poiché i criteri di valutazione del bene
e del male sono variabili in società e culture diverse non è
possibile trovare alcun principio morale universale, alcuna
concezione del bene e del male che valga o possa valere per tutti gli
esseri umani. Vorrei sottolineare le ultime parole: che valga o possa
valere per tutti gli esseri umani. Non si chiede che un certo
principio sia applicato ovunque, ci si domanda se tale principio
possa interessare gli esseri umani anche laddove non è
applicato. Prendiamo la democrazia: che non sia applicata ovunque è
una ovvietà, che in paesi non democratici la coscienza democratica
sia alquanto limitata è un’altra ovvietà. Da questo però non
discende che la democrazia non possa interessare gli uomini che
vivono in paesi non democratici. Discorsi analoghi possono farsi per
la dignità della donna. Che non si tratti di un valore ovunque
perseguito è evidente, ma da questo discende che non interessi né
possa interessare tutte le donne, anzi, tutti gli esseri umani? E’
quanto meno assai dubbio. I relativisti partono da un evidente dato
empirico quando sottolineano la diversità di molte norme morali.
Dovrebbero però stare più attenti a ciò che i dati empirici dicono
realmente. Basta aver occhi per vedere per constatare che certi
valori interessano anche gli esseri umani che hanno la ventura di
vivere in società in cui vengono negati. La feroce determinazione
dei fondamentalisti islamici nel rifiutare qualsiasi “contaminazione”
con quanto è occidentale si spiega proprio con questo. A differenza
dei relativisti occidentali i fondamentalisti islamici sanno
benissimo che se posti nella condizione di scegliere moltissimi
islamici accetterebbero alcuni valori del “corrotto” occidente,
da qui il loro impegno nella lotta a morte contro l’occidente.
L’universalità di certi valori è dimostrata proprio da chi li
combatte senza quartiere.
Una volta stabilito che
ogni cultura ha i suoi valori morali il relativista ripropone il
solito appello alla tolleranza. “Non cerchiamo di imporre a tutti i
nostri valori” afferma “rispettiamo le culture diverse, non
comportiamoci da imperialisti”. In un paese esiste il divorzio, in
un altro l’adultera può essere lapidata... che importa? Ognuno ha i
suoi valori, la sua cultura. Non bisogna essere intolleranti,
pretendere che tutti abbiano la nostra concezione del bene e del
male, cianciare di “superiorità” o “inferiorità” delle
culture: accettiamo il diverso...
Ma questa tolleranza,
questa “accettazione del diverso” di cui tanto parla il
relativista non è in fondo un valore universale? La tolleranza non è
affatto praticata in tutte le culture, al contrario. Non tutte le
culture rispettano il “diverso”, al contrario. E allora? Non è
“imperialistico” fare di un valore che solo certe culture
accettano un valore universale? Se qualcuno dice: “la tolleranza
non è un mio valore, il mio valore principale è la lotta a chi è
diverso da me, questa è l’essenza della moralità”, se qualcuno
dice questo, che si deve fare? Se si accettano le premesse del
relativista assolutamente nulla, si deve accettare di
essere aggrediti magari belando qualcosa sulla necessità del
“dialogo”. Non si tratta di un caso teorico. Il modo in cui vasti
settori della sinistra “pacifista” hanno reagito agli attacchi
dell’11 Settembre 2001 è significativo.
Il relativismo morale
si presenta come una dottrina della pace e della tolleranza. In
realtà è una dottrina che, se coerentemente perseguita, dovrebbe
farci accettare tutto. Ogni essere umano fa parte di una civiltà, tutto ciò che facciamo avviene in un contesto culturale. Se
la diversità dei contesti ci impedisce di condannare o assolvere
allora dobbiamo accettare tutto, ma proprio tutto. Per i
nazisti il massacro degli ebrei era qualcosa di meritorio, perché
dovremmo essere tanto “imperialisti” da condannarli? E se a noi,
si, proprio a noi, venisse in mente di regolare i conti con gli altri
a suon di bombe atomiche chi avrebbe diritto di criticarci? Altro
che tolleranza! Il relativismo morale, distruggendo ogni tipo di
valore universale lascia che sia la pura forza, meglio, la violenza, a decidere di tutto.
Se tutto questo non
appare troppo chiaramente lo si deve, di nuovo, al fatto che i relativisti non
sono coerenti. Non solo erigono la tolleranza sempre e
comunque a valore universale proprio mentre negano ogni
universalità, ma sommergono di critiche l’occidente accusandolo di
immoralità nello stesso momento in cui riducono la norma morale a
una sorta di appendice del contesto culturale. Il relativismo appare
in questo modo per quello che è: una forma
di odio dell’occidente verso sé stesso. Forma di odio che fa della
parzialità la propria norma suprema, che usa sempre il metodo dei
due pesi e delle due misure. All’occidente nulla è permesso, agli
altri è permesso tutto. Il relativismo serve ad assolvere i
terroristi islamici ma non chi fa loro la guerra, serve a capire le
“ragioni” dei ragazzi-bomba palestinesi ma non quelle degli
israeliani. Nulla come il relativismo morale mette oggi in pericolo
la vera tolleranza, la ricerca di un vero dialogo con l’altro, di
una pace basata su basi solide.
Il relativismo assume
spesso la forma del decustruzionismo, giocattolo filosofico alla moda
in cui è maestro il filosofo francese Derida, ora scomparso. Di che
si tratta? Di questo molto semplicemente: si prende un concetto, lo
si analizza e se ne mettono a nudo le contraddizioni interne fino a
svuotarlo di ogni contenuto. Nel libro “senza radici” Marcello
Pera mette in evidenza questa procedura citando due esempi di
“decostruzione”. Si tratta dei concetti di ospitalità e
democrazia.
Essere ospitali
significa accogliere l’altro. Ma noi non ci limitiamo ad accogliere
l’altro, lo vogliamo integrare nella nostra società, fargli
condividere i nostri valori, rispettare le nostre leggi. In questo
modo però l’altro viene trasformato in uno di noi, cessa di essere
un “lui” per diventare un “noi”. Ospitando l’altro lo si
distrugge in quanto altro, e questa è la negazione del concetto di
ospitalità. Se invece lasciamo che l’altro resti tale, non
cerchiamo di integrarlo e lo releghiamo in un ghetto, egli prima o
poi ci combatterà per farci diventare come lui e anche questa è la
negazione del concetto di ospitalità.
Bello slalom!
Passiamo ora alla democrazia. In democrazia tutti possono concorrere
alle elezioni, ogni limitazione della possibilità di partecipare a,
e magari vincere la, contesa elettorale costituisce la negazione del
concetto di democrazia. Ma chi vince le elezioni può non essere
rispettoso delle regole democratiche ed usare il potere
democraticamente conquistato per distruggere la democrazia. Anche
questo ovviamente nega il concetto di democrazia.
Il gioco potrebbe
continuare: ospitalità, democrazia e una quantità indefinita di
concetti sono intrinsecamente aporetici e quindi privi di senso. Che
senso ha quindi schierarsi per la democrazia? O propugnare
l’ospitalità? Nessuno, una scelta vale l’altra, è relativa
(appunto) ai gusti, alle abitudini di ognuno di noi.
Peccato però che,
una volta privati di ogni senso i concetti lo stesso decustruzionismo
diventi insensato. Proviamo a decostruire il decostruzionismo, nulla
è più facile. Per decostruire un concetto bisogna che quel concetto
abbia un senso. Posso dire: “usare il potere democraticamente
conquistato per distruggere la democrazia nega il concetto di
democrazia” solo se conosco cosa designa tale concetto. Si può
decostruire un concetto solo se questo ha un senso ma la
decostruzione priva di senso i concetti. Il decostruzionismo si basa
su, e nel contempo annulla il, senso dei concetti, si tratta quindi a
sua volta di un concetto aporetico e quindi insensato.
Ma, a prescindere dalle
precedenti considerazioni, è proprio vero che l’attività
distruttrice della decostruzione è tanto efficace? Vediamo.
Riprendiamo l’esempio
dell’ospitalità. Ammettiamo pure, in prima battuta, che essere
ospitali significhi integrare l’altro tanto profondamente da farlo
cessare di essere un altro. Ebbene, perché questo dovrebbe fare a
pugni col concetto di ospitalità? Se io accolgo un estraneo nella
mia famiglia e nel corso degli anni questi si trasforma per me in un
figlio io non sono stato ospitale quando lo ho accolto? Il processo
nel corso del quale l’estraneo diventa figlio non è iniziato con
un atto di ospitalità e non si è basato per lunghi anni sulla
ospitalità? Il massimo che si può dire è che alla fine, dopo un
certo lasso di tempo, l’ospitalità può trasformarsi in qualcosa
d’altro, ma questo non rende affatto aporetico il suo concetto. Se
accolgo in casa mia una donna disperata e senza nulla al mondo sono
ospitale. Se dopo dieci anni me ne innamoro e la sposo il rapporto
che esiste fra noi non è più di ospitalità ma questo non dimostra
affatto che per anni non lo sia stato. Inoltre, chi ha detto che per
essere ospitali occorra integrare l’altro in maniera tanto totale e
profonda da fargli cessare di essere un “altro”? Un cinese che
vive in Italia non deve cambiare religione, abitudini alimentari o
concezioni metafisiche. Non deve neppure cessare di amare la sua
terra d’origine o di mantenere legami con essa. Deve solo
rispettare chi lo ospita, assimilarne cultura e tradizioni, imparare
la sua lingua, non assumere atteggiamenti conflittuali, obbedire
alle leggi del paese ospitante. L’ospitalità è processo di
integrazione ma è anche dialogo fra ospitante ed ospitato, scambio
di idee, confronto di esperienze diverse. Integrarsi non vuol dire
negare le proprie origini, vuol dire essere in grado di cambiare, di
vivere in un contesto nuovo, di instaurare nuove relazioni.
L’integrazione è un processo di modifica e insieme di
conservazione, in qualche modo simile al processo di modifica e
conservazione che è presente nel divenire di ognuno di noi. Ogni
adulto vive in un ambiente che è più o meno profondamente diverso
da quello in cui viveva da bambino, ognuno di noi deve in qualche
modo “integrarsi” giorno dopo giorno in un contesto sociale in
continua evoluzione. Questo distrugge forse le nostre radici? Fa di
noi degli “assolutamente altri” rispetto a quello che eravamo
dieci o venti anni fa? No ovviamente.
Veniamo ora alla
democrazia. Certo, più di una volta forze politiche antidemocratiche
hanno usato la democrazia per distruggerla. Hitler è arrivato al
potere tramite elezioni democratiche, è vero. Appunto per questo la
democrazia ha non solo il diritto ma anche il dovere di difendersi,
anche con la forza se occorre. Impedire ad una forza politica di
partecipare alle elezioni è sicuramente un atto antidemocratico, ma
impedirle di usare il potere democraticamente conquistato per
distruggere la democrazia non lo è. Se si ha la certezza che una forza politica userà
il potere per distruggere la democrazia può addirittura essere
lecito interdire a questa forza la partecipazione al voto. Era
antidemocratico vietare nel dopoguerra l’attività politica del
partito nazista? Sarebbe antidemocratico impedire negli Usa ad un novello Bin
Laden di candidarsi alla presidenza?
La democrazia non è solo
un procedimento che assegna il governo di un paese a chi ha ottenuto
più voti alle elezioni. E’ un sistema complesso che esige insieme
il governo della maggioranza ed il rispetto delle minoranze, la
libertà di pubblica discussione dei programmi politici, il rispetto
delle fondamentali libertà individuali. A volte possono sorgere
contrasti fra queste aspetti tutti essenziali del concetto di
democrazia. Se si tiene conto di questo l’uso di misure che,
astrattamente considerate, possono esser giudicate non democratiche
appare non contraddittorio col concetto di democrazia. Certo, è
possibile che l’uso di certe misure vada ben oltre gli intenti
originari e finisca per stritolare la democrazia, questo non prova
però l’aporeticità del concetto ma solo la sua
complessità.
Il relativismo culturale
assegna una grande importanza alla storia e, nella storia, allo
sviluppo delle civiltà. L’universalista è un ingenuo seguace di
valori “astratti”, avulsi dal contesto storico e sociale, il
relativista invece colloca tutto nel contesto, sta con i piedi per
terra, non perde mai il contatto col divenire storico.
In realtà il
relativismo è del tutto incapace di spiegare proprio l’evoluzione
storica. Se il relativismo, inteso in senso forte, fosse vero allora
sarebbe proprio il sorgere, lo svilupparsi ed il perire delle civiltà
a risultare del tutto inspiegabile.
Inteso in senso forte
il relativismo socio-culturale fa dipendere l’uomo, le sue idee, il suo
operato dal contesto sociale in cui egli vive. Se questo fosse vero
non si capirebbe come sia potuto sorgere un contesto sociale. Il
primo “contesto” in cui sono vissuti gli esseri umani non era un
contesto sociale: la natura selvaggia è stato il primo
contesto con cui l’uomo ha dovuto fare i conti. Se il contesto
determinasse tutto non si capisce come l’uomo abbia mai potuto
uscire dallo stato di natura, come la storia sia potuta iniziare.
Considerazioni
analoghe possono farsi se si pensa alla nascita, allo sviluppo ed
alla decadenza di molte civiltà. Ogni civiltà nasce e si sviluppa
precisamente perché gli esseri umani vanno oltre il contesto sociale
in cui vivono. Una civiltà nasce e si sviluppa in costante
confronto, più o meno pacifico, con altre civiltà. Nessuna civiltà
si è mai sviluppata senza assimilare elementi di altre civiltà. Lo
scambio fra civiltà, l’assimilazione da parte di una civiltà di
culture, valori, istituzioni di altre civiltà sono una costante
della storia. Si riduca l’uomo a appendice del “contesto” e
diventano incomprensibili il commercio, gli scambi culturali, gli
incontri e gli scontri fra i popoli. Si, anche gli scontri, anche le
guerre. Non si fanno guerre con chi è assolutamente diverso da noi.
Si fanno guerre con chi è diverso ma nel contempo è simile a noi.
Si combatte chi interessato a cose a cui anche noi siamo interessati,
ha valori che sono in contrasto con i nostri ma che ritiene possano andare bene anche per noi (ed in effetti noi potremmo
accettare di subirli se costretti con la forza). Si fanno guerre
economiche perché entrambi i contendenti mirano a certi beni, guerre di religione perché entrambi credono in una
divinità, spesso addirittura nella stessa divinità, guerre
dinastiche perché entrambi vogliono rafforzare la propria dinastia.
Gli uomini si combattono perché sono simili oltre che diversi. Se
l’uomo fosse una mera appendice del contesto non lotterebbe con chi
fa parte di contesti diversi, l’indefinita perpetuazione del
proprio contesto sarebbe la sua unica preoccupazione. Per il
contestualismo storico-sociale l’uomo è il prodotto della storia;
è vero il contrario: l’uomo ha una storia perché non è il
mero prodotto del divenire storico.
Ma l’universalista è
davvero così ingenuamente irrealista come lo si descrive? E’ vero
che chi crede in valori universali è cieco al contesto storico
sociale, non tiene conto della storia? No, a meno che si tratti di un
universalista sciocco e dogmatico. In molti casi anzi è proprio il
relativista a cadere in un irrealismo ingenuo. I relativisti
anti-occidentali ad esempio parlano dell’imperialismo degli antichi
Romani con lo stesso livore con cui condannano il presunto
imperialismo Usa di oggi. I massacri di cui si sono rese responsabili un po’
tutte le grandi potenze occidentali due, tre, cinque secoli fa
vengono moralmente condannati senza tenere alcun conto del contesto
storico, della cultura dominante in quelle epoche lontane. Il
contesto storico, ottimo per giustificare i crimini di Stalin (o
meglio, per trasformare quei crimini in “inevitabili costi del
progresso”) scompare di fronte alla constatazione del tristissimo
fenomeno dello schiavismo nella Grecia antica. L’odio per
l’occidente in tutte le sue forme trasforma a volte il “realistico”
relativista nel peggiore degli idealisti dogmatici.
L’universalista
però non è, o non è necessariamente, un idealista dogmatico, tiene
conto della storia e dei suoi contesti, ne tiene conto meglio del
relativista.
Per l’universalista
esistono alcuni valori che interessano tutti gli esseri umani,
indipendentemente dai contesti storico-sociali in cui essi vivono.
Tuttavia questi valori vengono applicati e perseguiti in maniera del
tutto diversa a seconda di questi contesti. Un esempio può chiarire
meglio il concetto. Gli uomini non amano essere sottoposti a
schiavitù, quale che sia il contesto in cui vivono preferirebbero
non essere imprigionati arbitrariamente, non essere torturati o
condannati per delitti che non hanno commesso. Diventare schiavo era
una prospettiva orribile ai tempi dell’antica Roma come lo è oggi,
ciò non ha impedito che per secoli la schiavitù sia stata una
istituzione presente ovunque o quasi. Questo è spiegabile. Ognuno
ama la propria libertà ma è molto meno sensibile alla libertà
degli altri. L’uomo è capace di giudizi morali ma è anche capace
di opprimere i suoi simili in maniera feroce, può anteporre il
proprio benessere al rispetto dell’altrui dignità. In contesti
storico-sociali caratterizzati da miseria e arretratezza è del tutto
naturale che questi fattori della nostra natura abbiano il
sopravvento. Se l’unico modo per creare ricchezza è far lavorare
alcuni come schiavi è realistico pensare che lo schiavismo prima o
poi possa prender piede. Nell’antichità l’alternativa era secca:
o miseria per tutti o ricchezza e cultura per pochi al prezzo della
degradazione di molti. L’universalista queste cose le vede bene e
capisce anche come in simili situazioni non solo possa essere sorta
la schiavitù ma sia sorta e sia profondamente penetrata nella
cultura e nel comune modo di pensare di interi popoli la
giustificazione teorica della schiavitù. Mentre condanna senza
riserve lo schiavismo l’universalista capisce le cause che lo hanno
fatto sorgere e non si sogna neppure di assumere atteggiamenti
astrattamente moralistici nei confronti di quei filosofi
dell’antichità che lo hanno in qualche modo giustificato. Nulla
sarebbe più sciocco che considerare “immorale” Aristotele perché
giustifica lo schiavismo anche se è doveroso oltre che legittimo
confutare le sue teorie su tale fenomeno. Per il relativista invece
la confutazione delle teorie di Aristotele sullo schiavismo è
inutile in quanto queste sono vere nel contesto in cui Aristotele
visse; d’altra parte se il relativista è un nemico dell’occidente
la condanna per lo Stagirita è certa, nessuna preoccupazione per il
“contesto” salverà in questo caso il grande filosofo dalla più
dura riprovazione morale.
Il contesto condiziona il
valore e, soprattutto, la sua messa in pratica. A volte riesce
addirittura a mettere a tacere il valore, lo espelle da sé come un
corpo estraneo, contrappone al valore universale altri valori che
sono propri del contesto e solo di questo. Il valore però non si
lascia distruggere e coartare, resta in tensione più o meno forte
col contesto, riemerge in forme diverse proprio quando lo si riteneva
morto e sepolto. Proprio la giustificazione aristotelica delle
schiavismo dimostra la corposa realtà di questa latente tensione fra
valore universale e contesto.
Aristotele non
considera lo schiavismo qualcosa di positivo, al contrario. Ridurre
in schiavitù Platone è stato un crimine, come sarebbe un crimine
ridurre in schiavitù un essere umano che non sia “naturalmente”
portato ad essere schiavo. Lo schiavo per Aristotele è tale perché
è nella sua natura esser schiavo. Un libero diventa schiavo perché
è schiavo in potenza, riducendolo in catene si mette in atto ciò
che potenzialmente egli era fin dall’inizio.
E’ fin troppo
facile evidenziare le aporie del discorso aristotelico. Lo stagirita
non fa altro che constatare un fenomeno empirico, l’esistenza della
schiavitù, e decide che questo fenomeno empirico altro non è che il
passaggio dalla potenza all’atto: la schiavitù esiste perchè
esistono esseri umani potenzialmente schiavi. Ma come si può, una
volta accettato tale procedimento, dire, ad esempio, che è stato un
crimine ridurre Platone in schiavitù? Il semplice fatto che questo
sia successo non dovrebbe dimostrare che Platone era “potenzialmente”
schiavo?
Al di là delle
aporie resta però il fatto che anche per Aristotele lo schiavismo è
un fenomeno negativo che può essere giustificato solo dal fatto che
lo schiavo è tale per natura. Non si coarta la natura umana
riducendo in schiavitù chi è già schiavo, anche se solo in
potenza, afferma Aristotele. Ciò significa che anche per lui l’uomo
non potenzialmente schiavo ha un valore e nessun contesto
giustifica la sua riduzione allo stato servile. La cultura della sua
epoca e la stessa impostazione generale della sua filosofia spingono
Aristotele a cercare di giustificare lo schiavismo che comunque gli
appare, anche alla sua epoca, un fenomeno odioso. Lungi dal
giustificare il contestualismo la difesa aristotelica dello
schiavismo dimostra che l’universalità del valore era ben presente
alla sua mente acuta.
Per concludere, si può essere realisti, figli del proprio tempo e
credere fortemente in alcuni valori universali. Si può valutare
l’importanza del contesto senza accettare il relativismo
contestualista. Ognuno di noi non è solo un astratto essere umano,
è, sempre, anche altre cose: occidentale, italiano, lavoratore, ecc
e tutte queste altre cose contano nel fare di lui ciò che è. Ma
resta sempre un uomo, un generico membro della razza umana. E anche
questo è importante, molto importante.