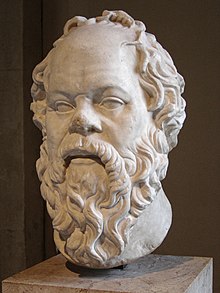Le reazioni della filosofia alla modernità ed alla crisi dei valori tradizionali che questa ha provocato sono state svariate. C’è chi ha accettato la modernità e la società aperta di cui essa è il correlato, rendendosi conto tuttavia di quanto fossero, e siano, reali i problemi che la sua vittoria ha creato. La reazione di gran lunga prevalente però è stata negativa. Il pensiero filosofico ha reagito alla perdita di centralità dell’uomo indotta dalla modernità cercando, molto semplicemente, di restaurare quella centralità. Che tale tentativo si sia concretizzato in un sistema che sostanzialmente giustifica l’esistente come quello di Hegel o in uno, quello di Marx, che colloca nel futuro la palingenesi globale del mondo e dell’uomo non ha poi, dal punto di vista strettamente speculativo, una importanza eccessiva. Tramite le filosofie della totalità l’assoluto rientra nel mondo e nella storia, l’uomo torna ad essere il protagonista di un disegno provvidenzialistico che gli restituisce, o gli restituirà, quel ruolo centrale che la rivoluzione scientifica gli aveva tolto; lo smembramento atomistico della società viene superato: la società torna, o tornerà, ad essere qualcosa di radicalmente diverso e superiore rispetto ai suoi membri, i comuni esseri umani.
Esiste un pensatore però
che da un lato accetta senza riserve la sfida della modernità, anzi,
considera positiva la crisi dei valori “sacri” che la modernità
ha determinato. D’altro lato rifiuta decisamente tutte le “idee
moderne”, tutti i valori di libertà, democrazia, eguaglianza, di
cui la modernità si è fatta portatrice. Si tratta, com’è
evidente, di Friedrich Nietzsche.
“Dio è morto”
afferma Nietzsche e questa affermazione segna per il grande filosofo
l’entrata nell’arena della storia dell’occidente del più
inquietante degli ospiti: il nichilismo. “Dov’è Dio? Voglio
dirvelo! Noi l’abbiamo ucciso, voi e io! Noi tutti siamo i suoi
assassini! Ma come abbiamo potuto farlo? Come abbiamo potuto bere
tutto il mare? Chi ci ha dato la spugna per poter cancellare via
l’intero orizzonte? Quale atto abbiamo compiuto per sciogliere
questa terra dalla catena del suo sole? Per dove si muove ora la
terra? Per dove ci muoviamo noi? Non continuiamo a precipitare? E
all’indietro, e di lato e per tutti i lati? C’è ancora un sopra
e un sotto? Non andiamo errando come per un nulla infinito? Non alita
su di noi lo spazio vuoto?” (1) Dio è morto, tutti i valori sono
crollati. Siamo entrati nell’epoca del nichilismo. Cos’è il
nichilismo? E’ la perdita di senso e di valore. “Cosa significa
nichilismo?” si chiede Nietzsche in “la volontà di potenza” e
risponde: “Significa che i valori supremi si svalutano. Manca uno
scopo, manca una risposta al: perché?” (2)
Per secoli l’uomo ha
pensato di essere il centro dell’universo, le sue azioni erano
sanzionate come buone o cattive da una legge morale avente fondamento
divino, è vissuto in comunità semi organiche in cui il posto di
ognuno era sanzionato dalla autorità indiscutibile della tradizione.
La rivoluzione scientifica e gli sviluppi successivi delle scienze da
un lato, l’affermazione della società aperta di mercato dall’altro
hanno messo in crisi questo insieme di certezze, opprimenti forse ma
senza dubbio consolatorie. La crisi di queste certezze lascia
letteralmente privo di punti di riferimento l’uomo. Quando
Nietzsche, nel brano sopra citato si chiede se esistono ancora un
sopra ed un sotto ha, letteralmente, ragione. La rivoluzione
astronomica ha cancellato dall’universo il sopra ed il sotto e
l’affermarsi della società individualistica di mercato ha
cancellato il sopra ed il sotto dalla società. L’uomo deve fare da
sé; in una società radicalmente desacralizzata avanza a tentoni
privo di bussole e punti di riferimento. Soprattutto è ormai privo
del più importante punto di riferimento, della fonte stessa del
valore e della verità: il trascendente. Se Dio è la fonte suprema
del bene, della verità e del senso la sua morte priva il mondo del
senso, della verità e del bene. Irrimediabilmente.
Ma in Nietzsche non c’è
alcun rimpianto di ciò che è crollato. Egli non cerca di
reintrodurre nel mondo gli idoli che sono caduti, di restaurare in
qualche modo i vecchi valori. Nietzsche non ama la modernità, ma non
la ama per ragioni diametralmente opposte a quelle dei suoi critici
romantici e/o rivoluzionari. Non protesta, come Tolstoi, contro le
conquiste della tecnica in nome di vetusti valori che queste hanno
espulso dal mondo. Per Nietzsche il crollo dei valori apre le porte
al nichilismo ma questo è un fatto inevitabile, lo è perché quegli
stessi valori erano nella loro essenza nichilisti, nichilisti
contro la vita. Per secoli presunte verità, religione, morale
hanno impedito la spontanea e rigogliosa affermazione della vita. La
vita è ribollire di forze primordiali, dionisiaca ebbrezza creativa,
passione istintuale, volontà di potenza. In Nietzsche come in
Schopenhauer la vita è qualcosa di essenzialmente non razionale, non
comprimibile in concetti, non incanalabile in un sistema di
imperativi morali. Fu Socrate colui che per primo cercò di mettere
la conoscenza razionale sopra la vita e per questo peccò contro la
vita, cercò di comprimerla, di soffocarla sotto il peso schiacciante
di una ragione scettica ed indagatrice. “Laddove in tutti gli
uomini produttivi l’istinto è una forza creativo affermativa e la
coscienza si rivela critica e dissuadente, in Socrate invece il
critico è l’istinto e il creatore è la coscienza: una vera
mostruosità per defectum. E invero noi avvertiamo qui un mostruoso
defectus di ogni disposizione mistica sicché Socrate sarebbe da
definire come lo specifico non mistico, nel quale la natura logica è,
per superfetazione, tanto eccessivamente sviluppata quanto è nel
mistico la sapienza istintiva. (..) Codesto istinto logico (…)
mostra una veemenza naturale, quale la incontriamo, con nostro
stupore e raccapriccio, solo nelle massime forze dell’istinto”
(3). La ragione socratica si ritiene superiore a tutto, più forte
della vita, che cerca di rendere intellegibile, e più forte della
stessa morte. “l’immagine del Socrate morente, come un blasone
dell’uomo che la conoscenza delle cause libera dal timore della
morte, è sospesa sulla porta d’entrata della scienza, e ne ricorda
a ognuno l’ufficio, che è quello, cioè, di far apparire
intellegibile e quindi giustificata l’esistenza” (4). La pretesa
socratica però è illusoria e non si tratta di una illusione priva
di conseguenze. L’invadente ragione socratica crea un altro mondo
accanto e contro il mondo terreno, un mondo “ideale” che
impedisce lo spontaneo sviluppo del mondo autentico. Altri mondi
fittizi sorgeranno sulla via aperta da Socrate; le religioni, prima
fra tutte il cristianesimo, porranno, accanto e contro il mondo
terreno altri mondi “più veri”, la morale cercherà di
ingabbiare il rigoglioso scorrere della vita in un sistema opprimente
di regole e proibizioni: “in quanto crediamo alla morale
condanniamo l’esistenza” (5) afferma Nietzsche in “la volontà
di potenza” e questa massima lapidaria esprime molto bene il
nocciolo del suo pensiero. Le morali, ed in particolare la morale
cristiana, altro non esprimono se non il risentimento del gregge, dei
malriusciti, degli scarti della natura e della vita pieni di
risentimento contro i migliori. “Il cristianesimo ha preso le parti
di tutto quanto è debole, abbietto, malriuscito; della
contraddizione contro gli istinti di conservazione della vita forte
ha fatto un ideale; ha guastato perfino la ragione delle nature
intellettualmente più forti insegnando a sentire i supremi valori
dell’intellettualità come peccaminosi, come fonti di traviamento,
come tentazioni” (6). La morale altro non è che la volontà di
potenza di coloro che non riuscendo ad affermarsi cercano di imporre
ai migliori vincoli e barriere travestendole da imperativi etici. In
questo la morale è il sintomo più evidente della “decadence”,
cioè del progressivo traviamento della vita.
Nietzsche dunque
condanna come nichilisti quei valori e quegli ideali il cui crollo ha
determinato l’insorgere del nichilismo. Il crollo di quegli
ideali e di quei valori ha distrutto solo un mondo spettrale, un
insieme di catene che impedivano il pieno dispiegarsi dell’esistenza.
Eppure l’uomo sente vuoto il mondo senza quegli spettri e quelle
catene, privo di valori egli vaga ora in un nulla infinito.
L’uomo, l’uomo di oggi, non è in grado di accettare il
nichilismo, di vivere gioiosamente in un mondo senza Dio e valori
supremi. Nietzsche irride questi timori: l’immagine di un mondo
ridotto a cieca forza vitale fa orrore a Schopenhauer, per Nietzsche
invece dobbiamo accettare questo mondo, accettarlo pieni di ottimismo
e gioia, dobbiamo esercitare in esso, in esso ed in nessun altro, la
nostra volontà di potenza, anzi, accettare un mondo simile significa
già esprimere la propria volontà di potenza. Il superuomo si
afferma dopo la morte di Dio e proprio questo dobbiamo proporci per
Nietzsche: superare l’abisso che separa l’uomo dal super uomo,
diventare super uomini.
E’ possibile allora
interpretare Nietzsche come un sostenitore della modernità?
Nietzsche potrebbe forse dolersi per la desacralizzazione del mondo?
I valori assoluti che la modernità ha fatto crollare non sono in
fondo gli stessi che Nietzsche condanna senza mezzi termini? E’
vero, la modernità è pervasa di spirito illuminista mentre
Nietzsche sottopone ad una critica serrata la pretesa razionalistica
di spiegare tutto, ma, in primo luogo, Nietzsche non è contrario
alla scienza ma solo alle sue assolutizzazioni, in secondo luogo
nella stessa modernità sono presenti posizioni scettiche e anti
sistematiche non troppo distanti in fondo da quelle di Nietzsche.
Eppure sarebbe un errore radicale pretendere di trasformare Nietzsche
in un sostenitore della modernità, lo sarebbe per una ragione assai
più importante dell’atteggiamento critico del grande filosofo nei
confronti della scienza. In realtà Nietzsche detesta la modernità
perché vede nell’affermarsi delle idee moderne la più piena
attuazione della morale del gregge. La moderna società di massa,
liberale, democratica, venata di socialismo rappresenta per Nietzsche
il trionfo del risentimento sociale, la attuazione più totale e
ripugnante di quegli ideali di pietà e compassione che sono propri
del cristianesimo e che gli fanno letteralmente orrore.
In “così parlò
Zarathustra” Nietzsche racconta dell’incontro fra Zarathustra e
due re in fuga dai loro regni. Ecco cosa dicono i re fuggiaschi al
profeta solitario: “Meglio in verità vivere fra eremiti e caprai
che non con la nostra plebe dorata, falsa, imbellettata, sebbene si
chiami buona società. Sebbene si chiami “nobiltà”. In essa
tutto è falso e marcio, e innanzitutto il sangue, grazie ad antiche
e brutte malattie e rappresentanti dell’arte medica ancora peggiori
delle malattie (..) E’ questo schifo che mi soffoca, che anche noi
re siamo diventati falsi, ci siamo travestiti e paludati nell’antica
e ingiallita pompa dei padri, medaglioni per i più stupidi e i più
furbi e per chiunque eserciti traffici col potere!” (7). La crisi
delle vecchie società fondate sul censo e il trionfo della società
individualistica di mercato permettono alle masse di abbandonare la
posizione subordinata in cui per secoli erano state relegate e di
diventare in qualche modo il centro della società. Anche i migliori
ora devono adulare i mediocri, gli stessi re devono inchinarsi di
fronte al popolo, l’uomo comune è diventato il centro di tutto, il
gregge sovrano. Ne “La volontà di potenza” Nietzsche esprime
concetti assai simili, con buona pace di chi considera quest’opera
una sorta di mistificazione postuma della sorella del filosofo. “Il
guazzabuglio sociale, conseguenza della rivoluzione, dell’aver
instaurato l’uguaglianza dei diritti, della superstiziosa credenza
nella uguaglianza degli uomini. I portatori degli istinti di
decadenza (del risentimento, del malcontento, degli impulsi
distruttivi dell’anarchia e del nichilismo) compresi gli istinti
servili, della viltà, del’astuzia e della canaglieria propri degli
strati sociali tenuti a lungo in soggezione, si mescolano al sangue
di tutti i ceti: dopo due, tre generazioni la razza è diventata
irriconoscibile, tutto è diventato plebe. Ne risulta un
istinto collettivo ostile alla selezione, ai privilegi
di ogni genere, così forte, sicuro, duro, crudele che ben presto gli
si sottomettono persino i privilegiati: chi vuole conservare
il potere adula la plebe, deve avere la plebe dalla sua parte
(…) l’ascesa della plebe significa ancora una volta l’ascesa
dei vecchi valori” (8).
Nelle società
organiche e censitarie la plebe stava al suo posto. La crisi di
quelle società trasforma i plebei in cittadini ma in questo modo i
plebei diffondono nella società tutta i germi della “decadence”.
I critici rivoluzionari o reazionari della modernità avevano
protestato contro la miseria che accompagna il sorgere della società
di mercato, avevano denunciato il senso di sradicamento che
accompagna la nascita ed il primo sviluppo del capitalismo. Anche
coloro che accettavano (e accettano) la modernità e la società
aperta avevano considerato gravi e reali i problemi che sorgono dal
disgregarsi delle vecchie comunità organiche e semi organiche.
Miseria, senso di sradicamento, emarginazione politica e sociale
erano apparsi a molti caratteristiche ineliminabili delle società
aperte di mercato, altri avevano considerato questi fenomeni gravi ma
risolvibili problemi che accompagnano il loro sviluppo. Nietzsche
ribalta completamente queste posizioni. Con incredibile anticipo sui
tempi individua la caratteristica di fondo delle società aperte di
mercato. Ben lungi dal fondarsi sulla miseria e l’emarginazione
economica, politica e sociale delle masse le società aperte sono
le prime autentiche società di massa della storia. L’economia
è finalizzata sempre più al consumo di massa, la politica eleva a
rango di nuova regina la pubblica opinione: inchieste di mercato e
sondaggi d’opinione accompagnano tutte le fasi della vita politica
ed economica delle società aperte. Con sguardo davvero d’aquila
Nietzsche comprende alla perfezione che miseria, emarginazione,
sradicamento sono fenomeni reali ma tutto sommato transitori della
nuova società mentre il coinvolgimento pieno delle masse nella vita
sociale politica ed economica ne costituisce la caratteristica
essenziale. In qualche modo su questo tema si può paragonare
Nietzsche a Von Mises, il grande economista austriaco che mostra con
molta chiarezza come la produzione nel capitalismo sviluppato abbia
come principale referente le classi popolari. Solo, ciò che per Von
Mises è un fenomeno positivo fa letteralmente orrore a Nietzsche.
Nietzsche ignora completamente l’enorme valore liberatorio
dell’ingresso di milioni di esseri umani nel circuito della
decisione politica, della produzione e del consumo. Nella società di
massa egli vede unicamente imbarbarimento dei costumi, trionfo del
risentimento sociale, volgarizzazione della società. L’uomo che
accetta un nichilismo attivo e virile, che accetta di vivere in un
mondo senza valori deve lottare per il ritorno di una società
aristocratica, contro i valori moderni. “E’ necessario che gli
uomini superiori dichiarino guerra alla massa! Non c’è luogo in
cui i mediocri non si radunino per diventare padroni! Tutto ciò che
rammollisce, addolcisce, valorizza il popolo o il femminino agisce a
favore del suffrage universel, ossia del dominio degli uomini
inferiori” (9). Anche se simili affermazioni possono
apparire oggi quasi intollerabili esiste un fondo di verità in
queste posizioni di Nietzsche. Che la società di massa sia
costantemente esposta ai vizi dell’involgarimento e del conformismo
che soffoca le individualità è vero. Lo hanno riconosciuto
pensatori liberali come Tocqueville e Ortega y Gasset. Ma individuare
i pericoli ed i problemi di una certa società è cosa ben diversa
dal liquidare quanto di buono, ed è molto, questa società ha
prodotto e produce. Il pensiero di Nietzsche però non è affatto
attento a questo tipo di distinguo. Il filosofo tedesco li avrebbe
con tutta probabilità considerati manifestazioni di spirito
filisteo.
Il rapporto di Nietzsche
con la modernità è complesso. La modernità secolarizza il mondo,
mette in crisi relazioni sociali consolidate da secoli, contribuisce
potentemente alla morte di Dio ed al crollo dei valori supremi; in
questo senso la modernità è l’araldo del nichilismo. Ma i valori
che la modernità mette in crisi sono a loro volta nichilisti,
nichilisti nel senso peggiore del termine, nichilisti contro la vita.
In questo può forse intravedersi un giudizio positivo di Nietzsche
sul ruolo della modernità, ma questo cauto giudizio positivo, se
esiste, non porta il filosofo tedesco ad avvicinarsi in nessun modo
al moderno. Non può farlo perché il moderno rappresenta per lui la
più piena e intollerabile affermazione dei valori della “decadence”,
cioè, di nuovo, di quanto di più nichilista, nichilista contro la
vita, si possa immaginare. Il moderno secolarizza il mondo ma esalta
l’umanità, mette in crisi modelli organici di società solo per
creare una società democratico individualista pervasa e dominata dai
valori della plebe. L’atomismo liberale rappresenta per Nietzsche
il più pericoloso veicolo per la diffusione della mentalità plebea,
dei valori plebei, della morale degli ultimi e dei malriusciti.
L’unica alternativa possibile alla morte di Dio non è il ritorno
ai vecchi valori. Nietzsche non contrappone al moderno la mielosa
riproposizione di idilliache società pastorali pervase di bontà e
solidarietà. Non contrappone alla vita come potenza la vita come
amore, non critica l’aristocrazia del denaro perché aristocratica
ma perché plebea, legata mani e piedi alle esigenze del gregge.
Nell’era della morte di Dio bisogna contrapporre al nichilismo
contro la vita il nichilismo della vita, ma solo un
nuovo tipo umano può farsi sostenitore di questo nichilismo
positivo: “deve venire alla luce una specie più forte, un tipo
superiore le cui condizioni di nascita e di conservazione siano
diverse da quelle dell’uomo medio. Il mio concetto, il mio simbolo
per questo tipo è, come si sa, la parola superuomo (…) quest’uomo
ha bisogno che gli sia ostile la massa, i livellati, ha bisogno di
sentirsene distante: sta sopra di loro, vive di loro” (10). L’uomo
di oggi non può vivere nel mondo privo di valori, non può accettare
sino in fondo la ferrea logica della vita come volontà di potenza.
“L’uomo è una corda” afferma Zarathustra “annodata tra
l’animale e il superuomo, una corda tesa sopra l’abisso” (11).
E così l’alternativa
di Nietzsche alla modernità si sostanzia nella proposta di una
società brutalmente gerarchica, spietata con gli ultimi,
lontanissima dagli ideali liberali, democratici e socialdemocratici
di cui il moderno è pervaso. Una società gerarchica assai più che
aristocratica, questo punto è essenziale per intendere bene il
pensiero di Nietzsche. Perché gli aristocratici veri, i migliori,
possono davvero affermarsi solo su una base di uguaglianza. Non
esiste vero merito, autentica considerazione per i migliori senza una
buona dose di uguaglianza diffusa. L’atleta migliore può essere
considerato tale solo se batte i suoi avversari in una competizione
giocata secondo regole uguali per tutti. Il grande imprenditore può
affermarsi nella sfida concorrenziale solo se in questa tutti sono
sottoposti alle stesse leggi, il grande artista, il genio possono
veder riconosciuto il loro talento solo se esiste ed è garantita a
tutti la libertà di pensiero ed espressione artistica. Senza base di
uguaglianza non esiste competizione, concorrenza, scambio e scontro
di idee, esiste solo lotta senza esclusione di colpi in cui a vincere
non sono necessariamente i migliori. Ma è questo probabilmente il
fondo del pensiero di Nietzsche. Migliore è ciò che la vita afferma
essere tale e la vita è forza cieca, impulso non regolato da legge e
regola alcuna, pura, fredda volontà, volontà di potenza (non a caso
Nietzsche deve tanto a Schopenhauer). E’ questa fredda essenza del
mondo che il superuomo deve accettare, senza riserve né piagnistei
morali. Sarebbe ingeneroso oltre che stupido instaurare frettolosi
parallelismi fra Nietzsche ed il nazismo. Tra l’altro Nietzsche,
oltre a non essere per niente antisemita, detestava lo stato. Il
grande filosofo era del tutto esente da quella venerazione
superstiziosa per lo stato che pervade invece la filosofia di
Hegel.Tuttavia non è possibile non intravedere luci sinistre dietro
a molte affermazioni di Nietzsche, affermazioni che, si è cercato
modestamente di dimostrarlo, non contrastano con l’essenza del suo
pensiero. Per Nietzsche, come per molti altri grandi pensatori, si
pensi a Marx, vale il detto che i grandi uomini commettono grandi
errori. Grandi e gravidi di tragiche e devastanti conseguenze.
Purtroppo.
Note
1) F. Nietzsche: La gaia scienza.
Citato: in Giovanni reale Dario Antiseri: Storia della filosofia.
Bompiani 2008 pag. 52 53.
2) F: Nietzsche: La volontà di
potenza. Bompiani 1996 pag. 9.
3) F. Nietzsche: La nascita della
tragedia. Edizioni del “sole 24 ore” 2007 pag. 358-359
4) Ibidem pag. 366
5) F. Nietzsche: La volontà di
potenza. Bompiani 1996 pag. 10
6) F. Nietzsche: L’anticristo. Citato
in Reale-Antiseri op. cit. pag. 37
7) F. Nietzsche: Così parlo
Zarathustra Rizzoli 1997 pag. 225
8) F. Nietzsche: la volontà di
potenza. Bompiani 1996 pag. 473. Sottolineature di N.
9) Ibidem pag. 470. Sottolineature di
N.
10) Ibidem pag. 476
11) F: Nietzsche: Così parlò
Zarathustra. Rizzoli 1997 pag. 12